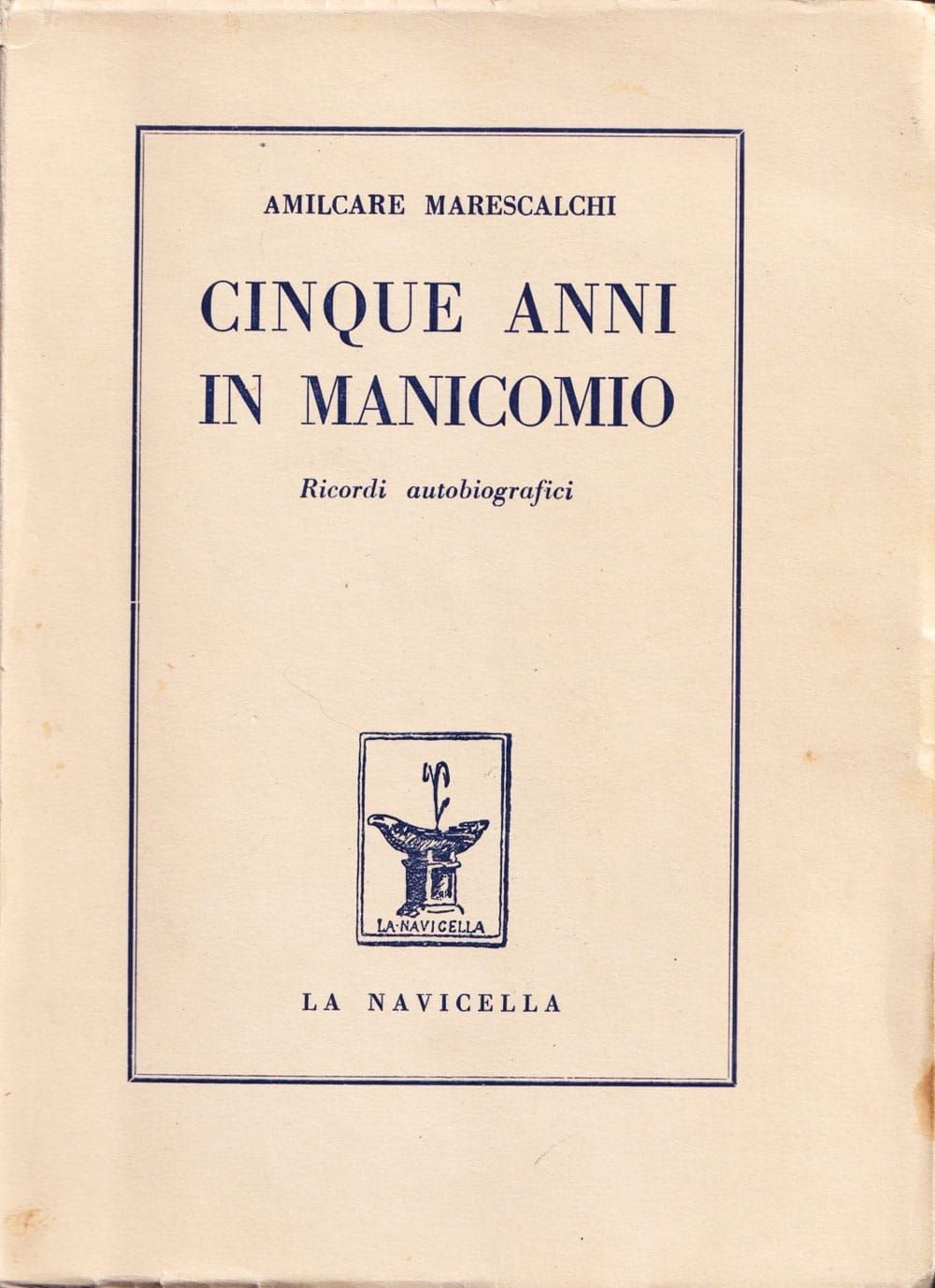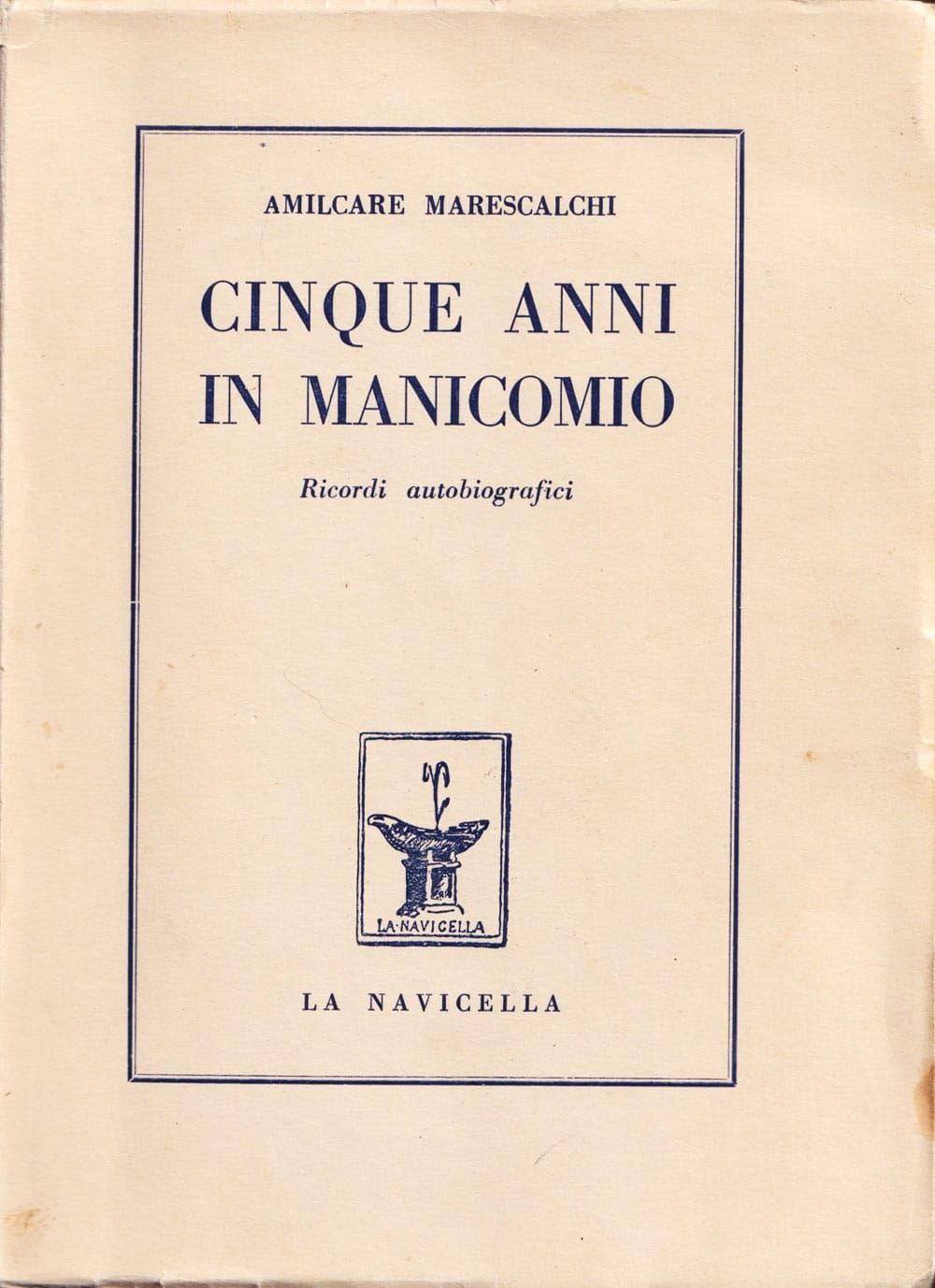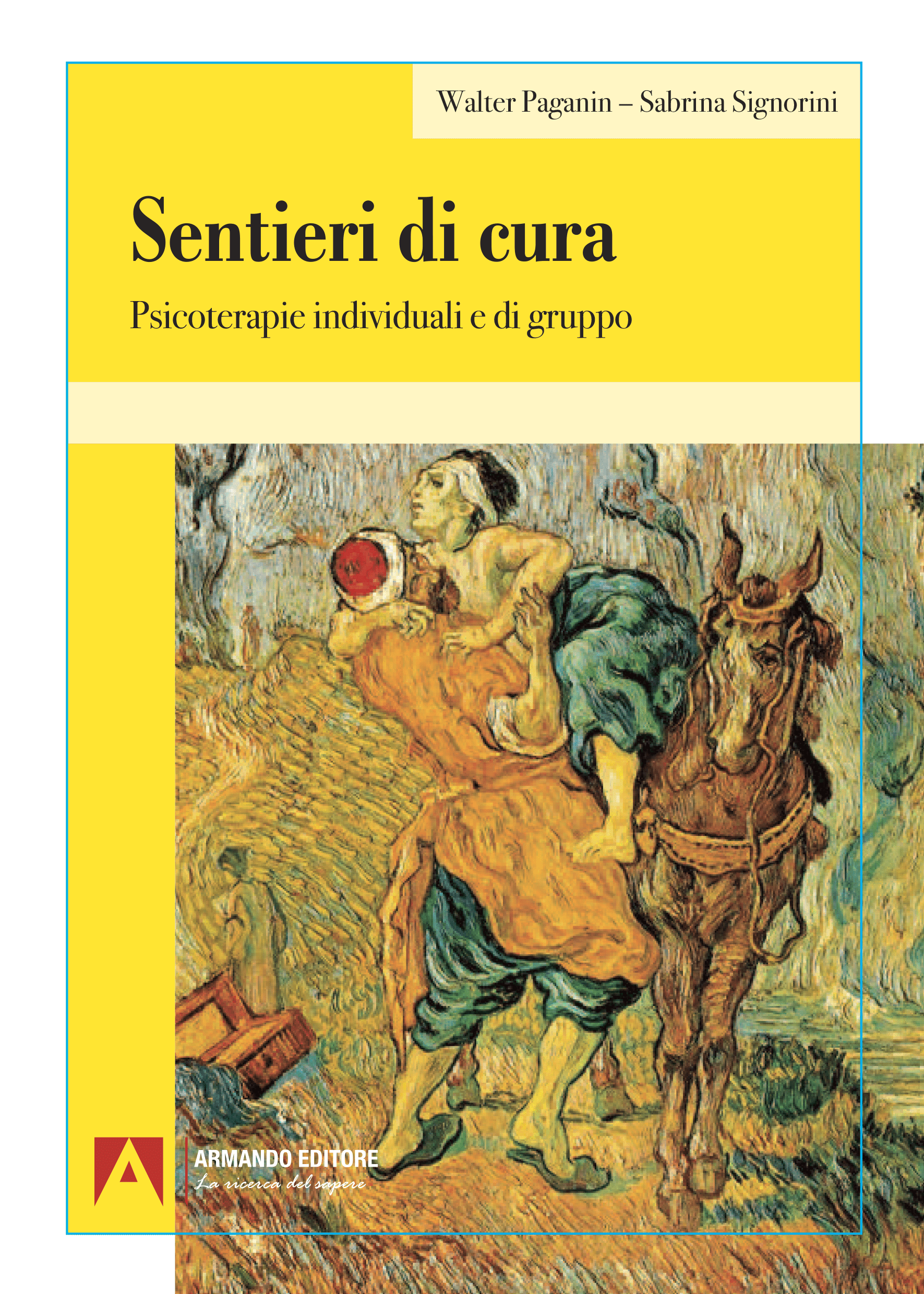Cinque anni in manicomio (1955)
Titolo originale:
Cinque anni in manicomio
Anno di pubblicazione:
1955
Prezzo di copertina:
800 lire
Casa editrice:
La Navicella, Roma
Numero di pagine:
220
ISBN:
Non presente
Contenuto aggiornato il:
14 Ottobre 2025
TAG:
Ricordi autobiografici
Cinque anni in manicomio – Ricordi autobiografici di Amilcare Marescalchi
Indice dei contenuti
Pubblicato nel 1955 dalla casa editrice La Navicella di Roma, Cinque anni in manicomio – Ricordi autobiografici è uno dei più importanti libri-testimonianza sulla vita all’interno degli ospedali psichiatrici italiani nel secondo dopoguerra.
Il suo autore, Amilcare Marescalchi, racconta con linguaggio limpido e sobrio le esperienze vissute in tre luoghi di internamento: un primo ricovero in un istituto chiamato Bellosguardo, poi al Policlinico e a Montemario (Roma, Santa Maria della Pietà), e infine all’Ospedale Psichiatrico di Volterra.
Fin dalle prime righe, Marescalchi chiarisce che Cinque anni in manicomio «non è romanzo, né storia romanzata», ma un racconto autentico: “pagine di vita vissuta” scritte per “portare un raggio di fede e di speranza a chi vede dinanzi a sé il buio completo” e per richiamare l’attenzione dei medici e degli amministratori sui problemi morali e organizzativi dell’assistenza psichiatrica.
“Non romanzo, ma vita vissuta”
Nel libro Cinque anni in manicomio, Marescalchi spiega che la sua intenzione non è letteraria, ma morale.
Scrive:
“Vi sono inconvenienti che si possono eliminare e si devono eliminare; altri che si possono attenuare e si devono attenuare; altri ancora che, non potendosi togliere, vanno compensati con provvidenze che li rendano più tollerabili.”
L’autore descrive con lucidità i mali dell’istituzione manicomiale: la burocrazia, l’indifferenza, la perdita d’identità dei ricoverati.
Non cerca il sensazionalismo, ma la comprensione, adottando uno sguardo partecipe e rispettoso.
Cinque anni in manicomio è, in questo senso, un testo di osservazione e di coscienza civile più che di denuncia.
Indice dei capitoli
(ed. La Navicella, Roma, 1955)
Perché?
PARTE PRIMA —
A Bellosguardo
CAP. I — Verso la catastrofe: Primi sintomi – Sitofobia – La prima allucinazione – Depressione psichica – L’infermiere e il soporifero – Ipnotismo? – Partenza!
CAP. II — A Bellosguardo: Il «morbus» – Ancora «sitofobia»… e maccheroni al sugo
CAP. III — Episodi lieti e tristi: Mania di persecuzione – Avvelenato?…
CAP. IV — Fobie, manie, allucinazioni, «voci interiori» a Bellosguardo
INTERMEZZO —
Al Policlinico
CAP. VI — Al Policlinico: Sei giorni … deliziosi – Per Montemario si cambia
PARTE SECONDA —
A Montemario
CAP. VII — Al Padiglione 2: «Mi ha mandato il Duce…» – Il vecchietto a bagno – Prime impressioni – «C…ielo che sorgi» – Il processo – Un’iniezione sprecata – Metto paura al diavolo
CAP. VIII — Ancora al Padiglione 2: Un bel tipo – Le caramelle – Il vecchino della pipa – Schifiltosi?!… – Storia di una multa – L’ovo al marsala – Il «Padre Eterno» – Spogliatevi!… – L’infermiere pazzo
CAP. IX — Al Padiglione 12: Accoglienze festose – Un infermiere ideale – Purga di nuovo genere – Il «water-clooset» – Barba e capelli
CAP. X — Ancora al 12: Lo sciacquo – Letti in fila – Il cambio della biancheria – Come festeggio il mio 60° compleanno – «Perché capisco!» – L’orologio di controllo – Un infermiere russo – La radio – Suor Maria fa miracoli
CAP. XI — Tipi e macchiette (serie prima): Il cieco nato – Pierino caposala – Giorgio e l’encefalitico – Un archeologo
CAP. XII — Roma–Volterra (scompartimento riservato): Si prepari! – Vestito a nuovo – Due Signori – Fascie e salsicce – Le donnette spaurite – Bellezze volterrane – Una cappa bianca – Un guanciale e il suo padrone
PARTE TERZA —
A Volterra
CAP. XIII — Prime impressioni volterrane: La sala omnibus – Un epilettico e sua madre – La tavola degli «aristocratici» – Lo «straccaletti» – Un infermiere scorbutico – Il primo bagno
CAP. XIV — La parola di un grande alienista: Un discepolo di Antonini – Diversità di metodo – Vito Viti – La voce del cuore
CAP. XV — I «tre stati» del nevrotico: Una fonte di preoccupazione – Interrogativi e proposte
CAP. XVI — Ancora la mania di persecuzione: Come sparve
CAP. XVII — I miracoli del tabacco: «Ne avessi voluti!…» – «Fùmaci sù!» – Duello rusticano – Un idillio
CAP. XVIII — Sotto le bombe: Il calzolaio di Empoli – «Sono ferito!…» – I tedeschi se ne vanno – Verso la Germania – Affari d’oro
CAP. XIX — Mi dò al commercio: Un poemetto fallito – La vecchia e le pere – Mele a iosa
CAP. XX — Passeggiate storiche: Una sepoltura – L’omino delle «pera» – «Vive l’Italie!» – Comodità inglesi – Che scalogna!
CAP. XXI — I sogni della fame: Un pugno sul muso – Patate lesse – Il gattino di Suor Olga – «Ah la guerra!» – Ladro di polli?… – Il professore
CAP. XXII — Tipi e macchiette (serie seconda): Gennariello – Il livornese – Un chirurgo – Brin e la contessa
CAP. XXIII — Storiellina di un Maresciallo
CAP. XXIV — Ultime ore: Dubbi e incertezze – Libero, finalmente
Bellosguardo, Montemario e Volterra
La prima parte di Cinque anni in manicomio è ambientata a Bellosguardo, nome con cui Marescalchi indica il luogo del suo primo ricovero.
Non ne specifica la posizione, ma lo descrive come una casa di cura o istituto privato, piccolo e isolato.
Scrive:
“A Bellosguardo tutto era silenzio, tranne i miei pensieri che facevano più rumore di una campana.”
Da lì l’autore passa a Roma, dove viene ricoverato prima al Policlinico e poi trasferito al grande ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà, identificato nel libro con la località di Montemario.
In queste pagine si nota un tono più amaro: Marescalchi osserva la freddezza dell’ambiente, la disciplina rigida e il distacco del personale.
“A Roma il malato è un numero. Le visite si fanno per dovere, non per interesse umano. I medici passano come ombre.”
Quando, dopo anni, arriva a Volterra, il tono cambia radicalmente:
“Qui almeno ci si conosce per nome. C’è chi parla, chi ascolta, chi prega. Non siamo numeri.”
Il confronto tra Roma e Volterra, che attraversa tutto Cinque anni in manicomio, rivela due mondi diversi: la capitale impersonale, dove domina la burocrazia, e la cittadella toscana, dove persiste una forma di umanità.
Critica della psichiatria e della burocrazia
Nel corso del libro, Marescalchi analizza anche il linguaggio medico e la distanza tra scienza e realtà.
Scrive che “le cartelle cliniche sono compilate per dovere d’ufficio”, sottolineando l’assenza di attenzione personale nei confronti dei pazienti.
La sua riflessione, pur nata da un’esperienza individuale, anticipa temi che torneranno decenni dopo con la riforma Basaglia: la necessità di considerare il malato di mente come persona e non come oggetto di studio.
Volterra: tra disciplina e umanità
Nella parte ambientata a Volterra, Marescalchi restituisce l’immagine più viva e complessa del manicomio.
Lo descrive come un luogo severo ma in cui sopravvive una dimensione umana, fatta di gesti, parole e solidarietà.
“Il manicomio non è tutto e solo tragedia. È anche commedia buffa. Ma il comico e il farsesco s’inseriscono nel tragico così profondamente che non si può ridere.”
La quotidianità, la convivenza, il lavoro nei reparti e i rapporti tra degenti e infermieri compongono un quadro realistico e, a tratti, commovente.
È da queste osservazioni che Cinque anni in manicomio trae la sua forza più duratura.
Valore storico e culturale
Cinque anni in manicomio è un documento essenziale per la storia della psichiatria italiana.
Non scritto da un medico ma da un ex degente, offre una prospettiva interna e sincera.
Accanto a opere come Corrispondenza Negata o Psychopathia Sexualis, il libro di Marescalchi rappresenta una delle rare voci che raccontano dall’interno l’esperienza del manicomio, con lucidità e dignità.
Conclusione
Cinque anni in manicomio non è soltanto un libro autobiografico: è una testimonianza di coscienza.
Con la sua scrittura semplice e priva di rancore, Amilcare Marescalchi restituisce un ritratto umano e veritiero del mondo manicomiale, contribuendo a formare una memoria storica che precede e prepara la stagione del cambiamento.
Rileggere oggi le sue pagine significa ascoltare la voce di chi visse “dentro” e trovò il coraggio di raccontare, trasformando il dolore in consapevolezza civile.